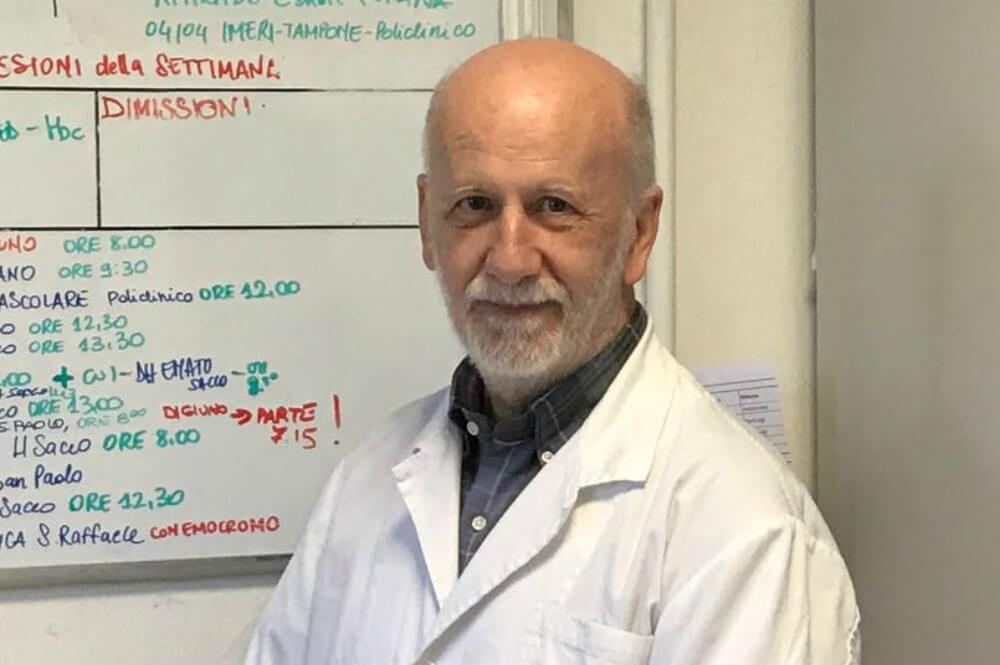Siamo nel Centro di Post Acute per Homeless, un piccolo reparto con due medici, una caposala, un’assistente sociale, cinque infermieri e cinque OSS per 20 posti letto riservati ai senza dimora e ai profughi dimessi dagli ospedali e dai pronto soccorso di Milano. Persone che hanno risolto la fase acuta della malattia, ma che hanno ancora bisogno di continuità assistenziale h24 per superare la convalescenza. Purtroppo, non avendo una rete parentale o persone amiche, sarebbero destinate a tornare in strada, compromettendo il buon esito delle cure ricevute.
Come è nata la tua collaborazione con Progetto Arca?
E’ cominciata per caso. Il medico, che poi ho sostituito, è un amico e mi aveva chiesto di affiancarlo nella sua esperienza. Ho visto il “mondo degli ultimi” e degli “invisibili”. Non potevo più dire di non aver visto niente, potevo girarmi dall’altra parte. Non mi sono girato e ho scelto. Ho conosciuto persone che, come tutte noi, sono colpite da malattia, le nostre stesse malattie, ma la loro fragilità fisica e sociale rende più drammatica l’esperienza di sofferenza e più devastanti i segni del suo passaggio. Hanno alle spalle dolorose storie familiari, di fallimento, di abbandono e di solitudine. Non possiedono nulla, dipendono per tutto.
Oggi molti pazienti ricoverati sono migranti. In quali condizioni arrivano nel Centro?
Tutti loro hanno vissuto una drammatica odissea che, quando presente, complica la malattia fino a compromettere gravemente lo stato di salute. Un ragazzo centroafricano sta perdendo l’unico rene trapiantato da vivente, che sua madre gli ha donato, perché non ha potuto assumere con continuità la terapia antirigetto. Spesso sono ragazzi che vivono esperienze fisiche e morali che si rivelano distruttive a livello psicologico e che richiedono un approccio specifico, così è nata l’etnopsichiatria.
Ma come avviene la comunicazione tra il personale sanitario e i profughi che vengono dalle parti più disparate del mondo?
La barriera linguistica rappresenta un vero problema, anche per pazienti provenienti da alcune aree della Comunità Europea. L’inglese, meno il francese, permette un margine di comunicazione. Curiosamente le diverse nazionalità dei nostri pazienti spesso ci permettono di trovare al loro interno mediatori linguistici provvidenziali. Poi, quando si tratta di dolore e sofferenza, anche il linguaggio dei gesti diventa sorprendentemente comprensibile e risolutore.
Però il progetto Post Acute nasce per rispondere al bisogno di malati senza dimora…
Penso che malattia, sofferenza, dolore, bisogno di cura non si distinguano per provenienza. Abou, nostro paziente senza dimora egiziano provato da una dolorosa storia familiare e lavorativa, è morto in ospedale dove è stato nuovamente ricoverato per il riacutizzarsi della grave malattia di cui era affetto. Durante il ricovero siamo andati a trovarlo, abbiamo continuato a procurargli il necessario. Quando ci chiamava al telefono ci ringraziava e ripeteva “voi siete la mia famiglia”. Questo commovente riconoscimento non mi era mai capitato in tutta la mia carriera professionale.
Se dovessi valutare questa esperienza?
La ritengo molto preziosa ma anche, non lo nego, molto faticosa e alcuni mi sibilano “ma chi te lo fa fare”. Vorrei sempre trovarmi in circostanze in cui poter dire “ho fatto tutto quello che è stato necessario” anziché “cerco di fare quel che posso fare”. Perché se è vero che la malattia, la sofferenza, il dolore, la morte sono uguali per tutti, non sempre lo è il diritto alla salute.